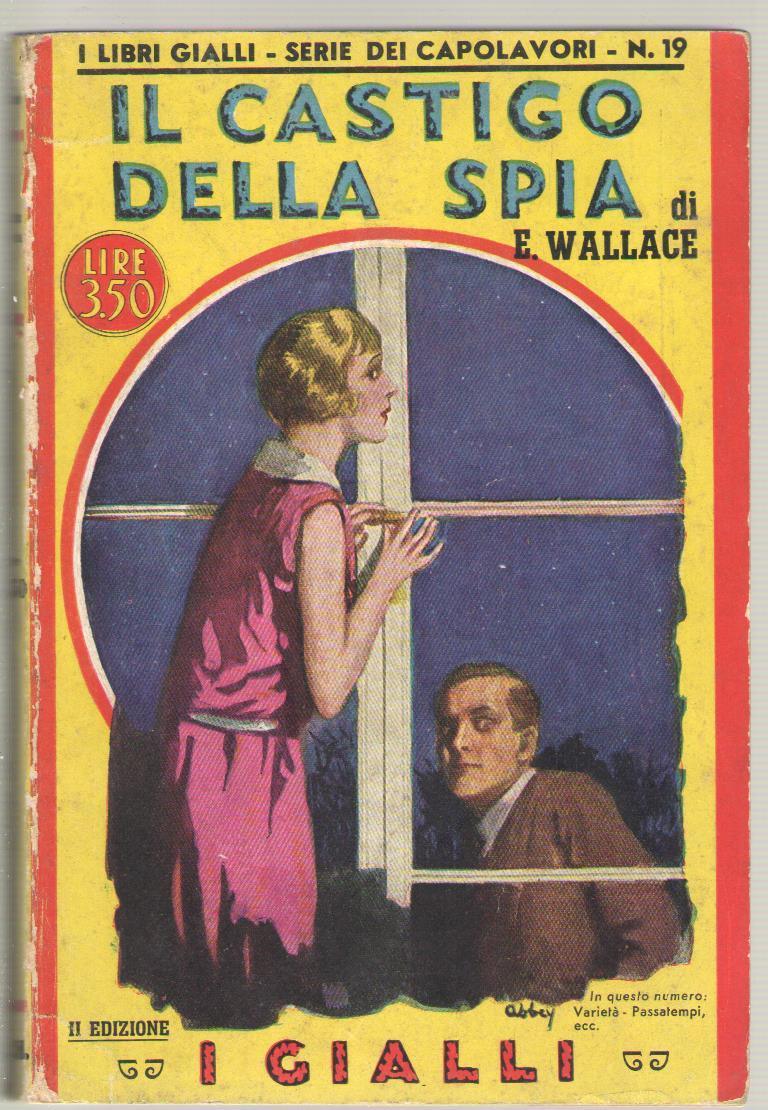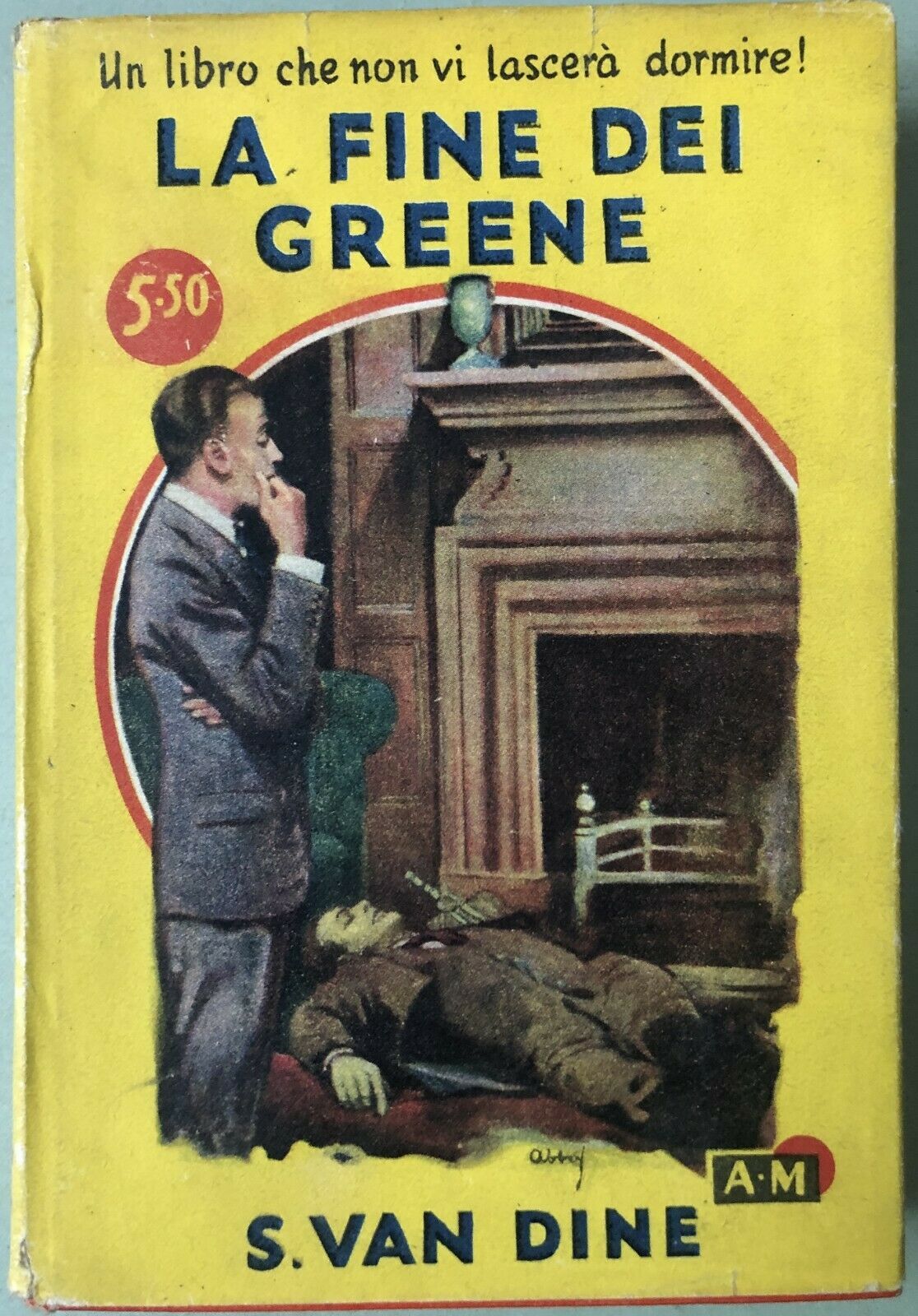«E allora, dottore, qual è il tuo verdetto?»Sedette sul lettino d'osservazione con le lenzuola avvolte intorno al corpopiegato ed elastico e ordinò all'infermiera, con decisione, di riportargli ivestiti, Poi guardò me, gli occhi azzurri e brillanti che senz'altro esprimevanocuriosità, ma non paura: e questo era strano, perché sapevo che si aspettavauna sentenza di morte.«Assoluzione, John» dissi onestamente. «Sei davvero indistruttibile. In formaperfetta, per un uomo della tua età, a parte quel ginocchio. Sarai mio buonpaziente e avversario agli scacchi per altri vent'anni.»Ma il vecchio John Delmar scosse la testa abbronzata.«No, dottore.» Parlava con voce calma e priva d'eccitazione, come se avessevoluto dire che oggi era martedì. «No, dottore, mi restano meno di tresettimane. Da parecchi anni, ormai, so che morirò alle undici e sette mattutinedel 23 marzo 1945.»«Sciocchezze» risposi. «Non c'è la minima probabilità, a meno che non tibutti sotto un camion. Il ginocchio è un po' rigido, e forse resterà così persempre, ma non c'è altro...»«Conosco la data.» La voce antica, sottile, esprimeva una convinzionesemplice e assoluta: «Vedi, l'ho letta sulla mia tomba». Non gli sembravaun'affermazione straordinaria. «Stamattina sono venuto per vedere se riuscivia dirmi di che cosa sarei morto.»Mi sembrava troppo equilibrato e padrone di sé per cadere vittima di stranesuperstizioni.«Te ne puoi scordare» gli assicurai calorosamente. «Sei più sano di tanti chehanno vent'anni di meno. A parte il ginocchio e qualche cicatrice assortita...»«Non credere che metta in dubbio la tua diagnosi: ma sono sicuro del fattomio.» Sembrava che volesse scusarsi ed era stranamente esitante. «Vedi,dottore, ho un curioso... dono, chiamiamolo così. A volte ho pensato diparlartene. Cioè, sempre che ti interessi...»Fece una pausa, diffidente.Il vecchio John Delmar mi aveva sempre incuriosito. Un uomo magro, dritto,sbiadito, con sottili capelli grigi e un paio d'occhi azzurri stranamenteluminosi, stranamente giovani; ancora agile e vitale, nonostante gli anni,zoppicava un po' a causa della ferita al ginocchio, ma conservava un passoleggero.Ci eravamo conosciuti quando era rimpatriato dalla Spagna, alla fine dellaguerra civile: mi aveva cercato per portarmi la notizia della morte di unamico, che non aveva un terzo dei suoi anni e che aveva combattuto come luicontro i franchisti. Mi era sembrato un vecchio soldato solitario, taciturno perquanto riguardava le sue imprese ma come me appassionato di scacchi e tuttosommato di buona compagnia. Possedeva una giovinezza di cuore, unavitalità instancabile e rara in un uomo della sua età; e il mio interesseprofessionale era stimolato dall'eccezionalità del suo corpo.Perché aveva sopportato molte prove.Era sempre stato reticente, anche se in quegli ultimi anni - pacifici suomalgrado - fui l'amico più intimo che avesse. Della sua vita lunga emovimentata mi aveva parlato solo per allusioni: era cresciuto, disse, nelWest della frontiera; quando era solo un ragazzo aveva impugnato la suaprima pistola in una faida per il bestiame, e in seguito era riuscito, non si sacome, ad arruolarsi nei Ranger del Texas senza aver compiuto l'età legale.Più tardi aveva prestato servizio nel famoso reggimento dei Rough Riders,poi aveva combattuto nella guerra boera e sotto Porfirio Díaz. Nel 1914 si eraarruolato nell'esercito inglese: per farsi perdonare, diceva lui, di avercombattuto contro di loro in Sud Africa. Quindi era stato in Cina e nel Rif,nel Gran Chaco e in Spagna. Era stata la permanenza in un campo diprigionia spagnolo a peggiorare le condizioni del ginocchio più debole; ilcorpo temprato da una vita avventurosa aveva cominciato a dare i primi segnidi stanchezza e quand'era rimpatriato era troppo vecchio per combattereancora. Lo avevo conosciuto appunto allora.