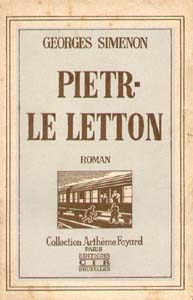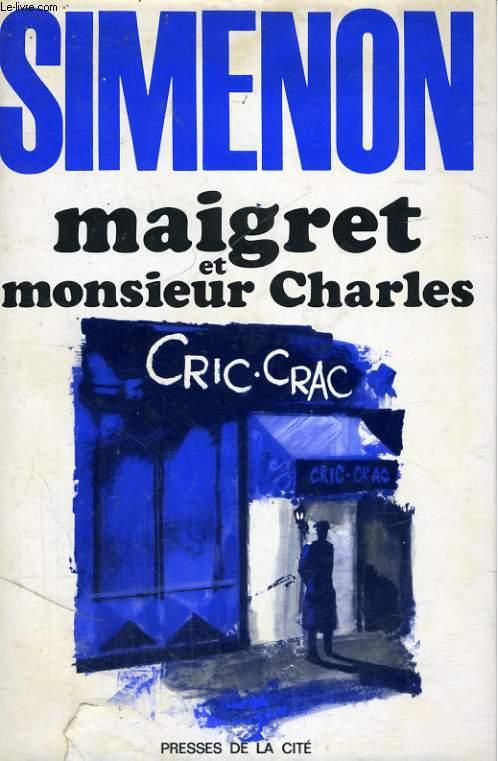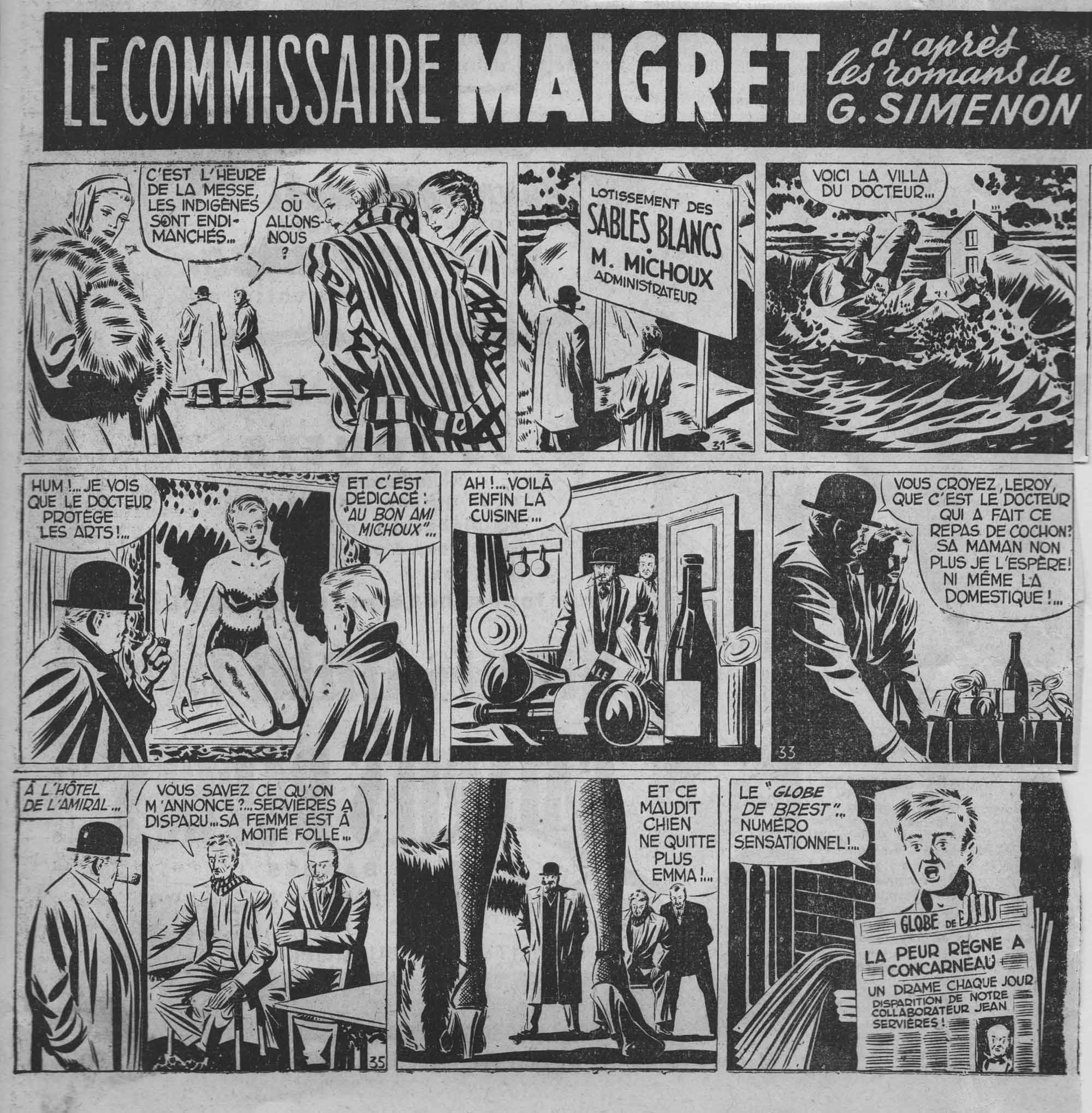Dei due uomini, uno era alto, magro e vestito di scuro; il secondo portava un abito color panna ed era piccolo, tozzo.
Roberto, fermo sulla soglia di casa, li squadrò con aria impaziente: aveva altro da fare, in quel momento. — Sì? — chiese.
— Sappiamo tutto — rispose l’uomo alto.
— Inutile che vi affanniate a negare — disse l’uomo tozzo.
— Ieri sera avete tagliato a pezzettini vostra moglie e l’avete sepolta in giardino, dopo avere raccontato a tutti che è scappata col vostro socio, Adriano Montini.
Roberto li fissava ad occhi sbarrati.
— Capisco la vostra sorpresa — disse l’uomo alto, accennando un sorriso affettato. — Credetemi, nessun altro lo verrà mai a sapere. È solo che la nostra... agenzia investigativa, per così dire, possiede mezzi straordinari.
— Davvero straordinari — disse l’uomo tozzo. — Ed è molto comprensiva.
— Vi firmeremo una regolare ricevuta — disse l’uomo alto, — oppure una dichiarazione, come preferite. Coi nostri nomi, indirizzi, e tutto quanto.
— Così non dovrete più preoccuparvi — disse l’uomo tozzo. — Saremo coinvolti quanto voi. Dovrete ammettere che è una bella garanzia. Il nostro motto è Ricatto sì, ma pulito. E teniamo molto a vedere soddisfatto il cliente.
— Purtroppo non accettiamo denaro in contanti, e nemmeno assegni. Soltanto gioielli ed opere d’arte. Quadri, tappeti pregiati, sculture, ci va bene tutto. Basta che abbia un certo valore, naturalmente. Nel vostro caso, pensavamo che una cifra dell’ordine di...
Una voce femminile, morbida, languida, arrivò dalla camera da letto. — Roberto? Chi c’è? Non possono aspettare, tesoro? Mi sento così sola, in questo letto...
I due uomini, all’unisono, si schiarirono la gola e sorrisero.
— Che tempismo eccezionale — mormorò l’uomo alto. — La povera signora Luciana è finita sottoterra da poche ore, e siete già riuscito a rimpiazzarla.
— Ma forse il rimpiazzo era pronto già da prima, socio — sogghignò l’uomo tozzo.
A quel punto, Roberto si infuriò. — Voi due dovete essere pazzi — strillò. — O ve ne andate da soli, o chiamo la polizia!
— Chiama la polizia! — cantilenò l’uomo alto.
— E magari metterete il giardino a disposizione per qualche piccolo scavo, eh? — insinuò l’uomo tozzo.
Roberto si girò verso la camera da letto. — Luciana! — urlò. — Mettiti addosso qualcosa e vieni un attimo qui!
— Luciana? — L’uomo alto strabuzzò gli occhi.
— Luciana, Luciana, mia moglie! — esplose Roberto. — Voi due stronzi venite a interrompermi mentre me ne sto calmo e tranquillo con mia moglie e pretendete di...
— Non l’avete fatta a pezzettini? — chiese l’uomo alto.
— Da quanto tempo siete sposati, per cortesia? — chiese l’uomo tozzo.
— Sei mesi — rispose la fantastica bionda che apparve sulla soglia della porta tra ingresso e camera da letto. Si era messa qualcosa molto in fretta, la prima cosa che aveva trovato, e si vedeva. A giudicare dal poco che il negligé nero nascondeva, nessun uomo sano di mente avrebbe mai assassinato una moglie del genere.
Una moglie come Luciana.
— Scu... scusateci — balbettò l’uomo alto.
— Un equivoco, un tragico equivoco — sussurrò l’uomo tozzo. — A volte anche le migliori agenzie investigative sbagliano.
— Fuori! — urlò Roberto, cianotico di rabbia.
Ma non era necessario. I due erano già scomparsi.
Mentre tornavano verso la macchina, che li attendeva in un vicolo a pochi isolati di distanza, i due uomini continuarono a litigare. Quello piccolo e tozzo, con l’abito color panna, tirava calci negli stinchi al secondo, che era alto e magro, e vestito di scuro.
— Imbecille — sibilava l’uomo tozzo, senza smettere di picchiare l’altro. — Uno sbaglio del genere! Con quello che ci costa ogni viaggio... Adesso chi ce li rimborsa, i soldi?
— Gli chiederemo il doppio — azzardò, timidamente, l’uomo alto.
— Bestia! — strillò l’altro. — Dovevamo prosciugarlo fino all’ultimo centesimo, giusto? E invece non riusciremo nemmeno a rientrare nelle spese!
— Oh, insomma, per un errore piccolo piccolo — gemette l’uomo alto. — Cosa sono dieci anni, dopo tutto?
— Sono la nostra rovina! — urlò l’uomo tozzo.
E, appena prima di salire sulla macchina del tempo, appioppò l’ultimo calcio negli stinchi al suo socio.





.jpg)





.jpg/220px-Laura_(1944_film_poster).jpg)