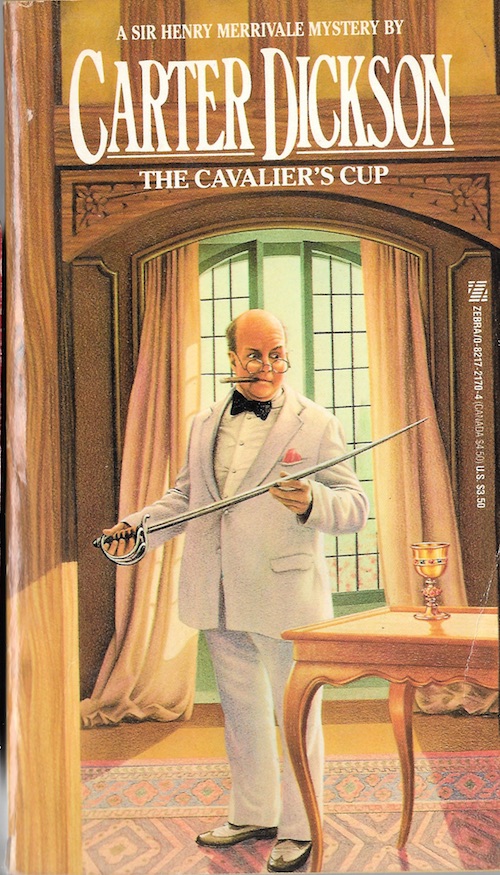(Ginevra, 15 settembre 1890 – Naarden, 21 novembre 1974)
Allievo di Lauber, si è qualificato come il maggior compositore svizzero del secolo scorso. Visse lungamente all'estero (a Parigi, a Roma e ad Amsterdam), entrando in contatto con le più diverse tendenze della musica europea del nostro secolo, ed è stato attivo anche come pianista e clavicembalista. Dal 1943 al '46 è stato presidente dell'Associazione dei Compositori Svizzeri e dal
1950 al '57 ha insegnato al Conservatorio di Colonia.
La formazione di Martin è stata lenta e graduale, e solo verso i cinquant'anni egli ha prodotto opere veramente decisive per l'individuazione della sua personalità. Inizialmente legato al tardo romanticismo germanico, ha risentito più tardi dell'impressionismo francese, ed è venuto in utile contatto con la
produzione di Stravinski, Hindemith e Bartòk, introducendo infine nella sua musica anche elementi dodecafonici. Egli resta però sostanzialmente un impressionista, e anche l'adozione della serie è in lui parziale, non tale da determinare un reale rivoluzionamento del linguaggio. L'ispirazione di Martin è fluida e piacevole, l'orchestrazione leggera ed elegante, l'equilibrio formale
quasi sempre esemplare. Senza aver fatto scuola nel contesto della storia musicale contemporanea, egli resta uno dei compositori più interessanti della sua generazione.
Si è cimentato come compositore teatrale nella Tempesta di Shakespeare (Vienna 1956), ed è autore di balletti, musica corale sacra e profana, di pregevole musica da camera e di un oratorio, Le Vin Herbé ( 1941 ), che conta tra le sue composizioni più personali.
Petite Symphonie Concertante per arpa, clavicembalo, pianoforte e due orchestre di strumenti ad arco (1945)
Composta su suggerimento di Paul Sacher, direttore dell'Orchestra da Camera di Basilea, questo lavoro nacque dall'idea di impiegare solisticamente quegli strumenti a corda che servivano in passato a eseguire il basso continuo: Martin scelse così l'organico dei tre solisti da contrapporre ai due corpi orchestrali formati da soli archi, con un accostamento che richiama lontanamente l'organico della Musica per archi, arpa, celesta e percussione di Bartok. Nonostante l'impiego, peraltro assai personale e libero, della tecnica dodecafonica, ne risulta una pagina colorita impressionisticamente, dove la felice invenzione tematica si scioglie in un trasparente disegno di timbri, presentando spesso anche accenti ritmici vigorosi e incisivi.
La prima parte della composizione, costruita secondo lo schema della forma-sonata ( « per vedere - come scrive l'autore - se la materia musicale che trattavo poteva prosperare e svilupparsi in questa forma bitematica »), presenta un " Adagio" introduttivo sfociante in un "Allegro con moto" (che presenta a sua volta una zona di distensione "Molto tranquillo"); segue un breve "Adagio" in cui vengono messi in rilievo, con squisiti effetti timbrici, i tre strumenti solisti, mentre conclude la partitura un "Allegretto alla marcia" dal carattere vivo e dai ritmi baldanzosi.