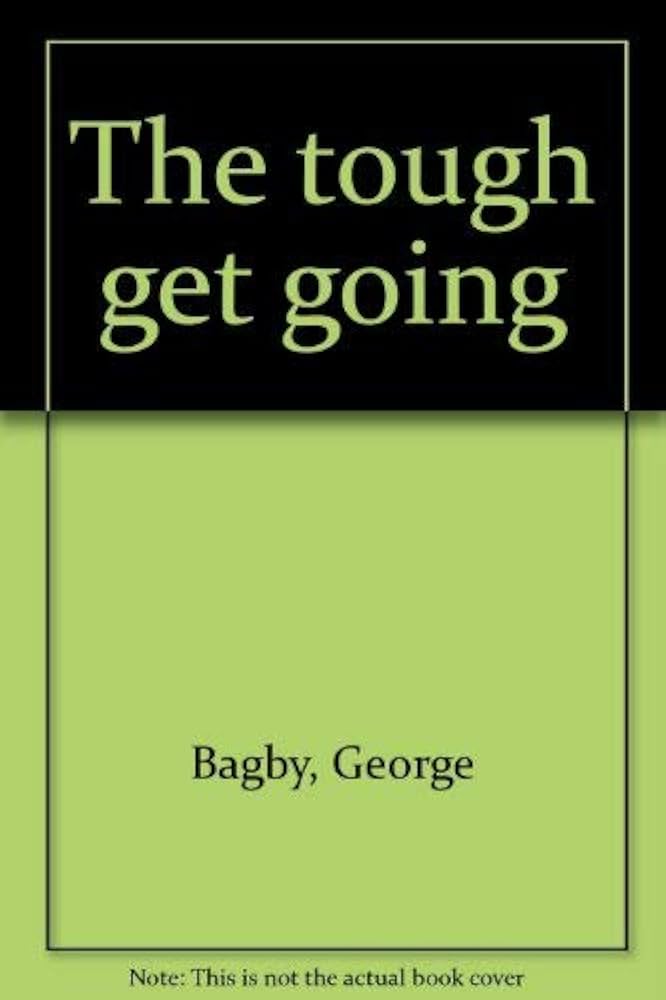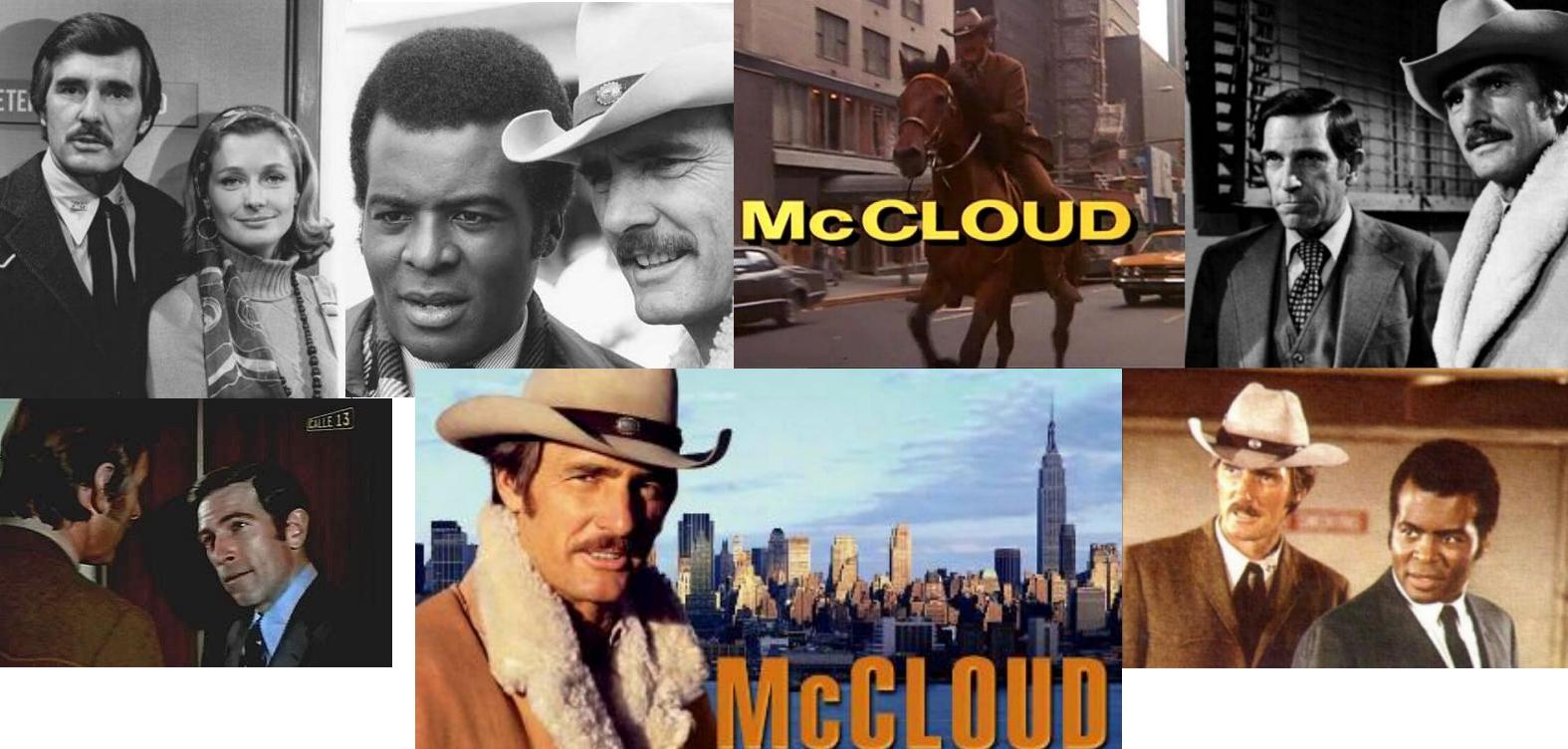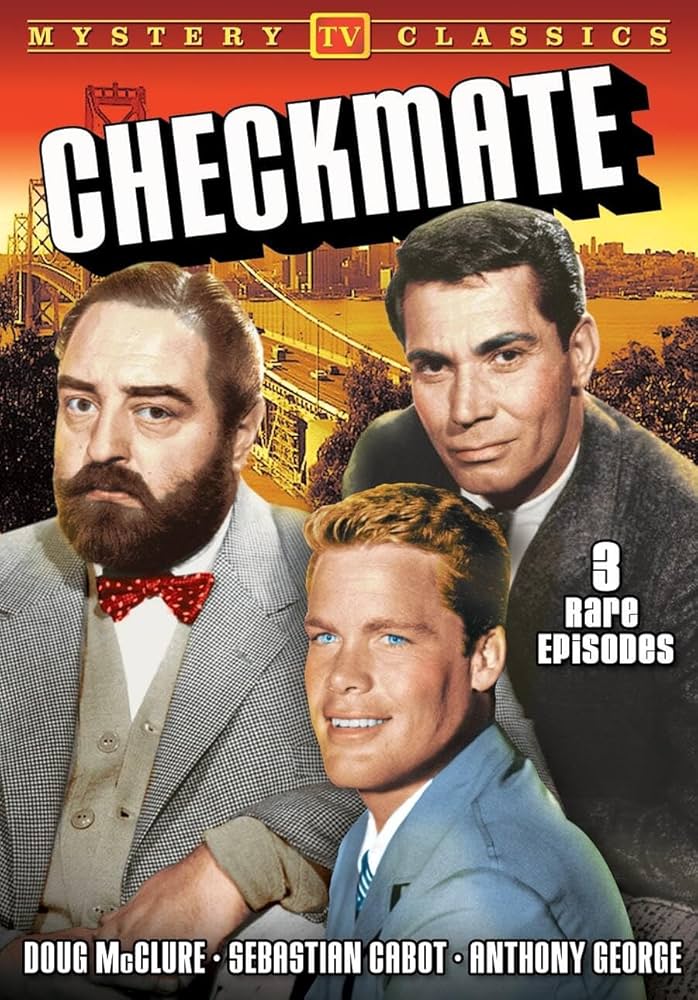Nella città quasi ai confini del grande Impero Asburgico la famiglia risiedeva ormai da tempo. Le origini tuttavia – almeno secondo una affascinante anche se non confermata ipotesi – ci portano in Savoia, una terra di montagna come il Tirolo, ma all’estremo nord ovest dell’arco alpino, e per la precisione a La Thuile, cittadina della Valle d’Aosta a sud del Monte Bianco già nota ai tempi dei romani, vicina alla Francia da cui la separa il colle del Piccolo San Bernardo. Una cittadina incantevole tra le montagne e i ghiacciai, in una valle dove scorre il torrente Rutor.
Il Tirolo, dove la famiglia Thuille si era trapiantata, faceva parte del grande Impero retto da Francesco Giuseppe. A Bolzano la vita era dunque quella di una città della periferia di uno Stato multietnico e multiculturale, un mondo di sicuri riferimenti e saldamente ancorato nella tradizione. La casa in cui nacque Thuille, il cui nome per intero era Ludwig Wilhelm Andreas Maria, si trova nel cuore della città, nella via della Mostra, là dove le cose anche oggi non sono davvero molto cambiate. Bolzano era all’epoca come adesso una città di intenso scambio culturale e commerciale. Era molto facile dunque incontrare i personaggi più differenti. C’erano attori, musicisti, intellettuali e commercianti, oltre ai viaggiatori soprattutto di passaggio. Da qualche anno esisteva la linea ferroviaria che collegava Verona a Bolzano e da lì a pochi anni la ferrovia sarebbe arrivata al Brennero. Dunque in città passavano i viaggiatori del nord diretti al sud, e altri che compivano il cammino inverso. Poi c’erano gli impiegati della amministrazione imperiale, il personale della guarnigione e i militari dislocati nel territorio. Nelle strette strade della città si potevano ascoltare accenti bavaresi, boemi, ungheresi, italiani, lingue e usanze diverse.
Per una città dedita per lo più al commercio, a Bolzano c’era una vivace vita culturale. Il borgomastro della città all’epoca era Joseph Streiter, anzi il Doktor Josepf Streiter, discendente di una ricca famiglia, avvocato e intellettuale, che dirigeva una società di concerti, il Musikverein. Oltre a questa associazione concertistica c’erano serate di quartetto, musica sacra nel Duomo e un’attività teatrale al Teatro della corona imperiale. Il direttore del quotidiano locale, il Giornale di Bolzano, era anche un compositore di Lieder. La musica dunque non mancava intorno al giovane Ludwig Thuille, che dimostrò subito talento e una precosissima maturità. Una compagna di giochi lo ricordava un bambino quieto e introspettivo, spesso perso nei suoi sogni. Tuttavia non rifiutava mai di partecipare alle birichinate tipiche dei ragazzini. Un’inclinazione alla vita e al sorriso che rimase un tratto del suo carattere e della sua musica.
Dai resoconti del tempo sembra che la vita musicale a Bolzano fosse vivace, cosa che del resto è nella tradizione austroungarica, dove la musica fa parte della vita quotidiana delle persone. Certo è che il giovane Ludwig Thuille ebbe modo di manifestare e sviluppare il suo talento. Oltretutto la musica era di casa anche nella vita familiare. Il padre Johann Thuille era un apprezzato benestante uomo d’affari, che commerciava in musica e oggetti d’arte. Nel suo negozio vendeva non solo sculture e quadri, ma anche partiture, trascrizioni d’opere per pianoforte e musica di consumo d’ogni genere, trattava pianoforti e noleggiava strumenti e oggetti musicali. Il giovane Ludwig iniziò presto a studiare e fu ammesso nella classe violino di Josef Anzoletti nella scuola dell’Associazione Musicale, e poiché nel Conservatorio cittadino venivano insegnati solo canto e strumenti orchestrali, Ludwig prese lezioni di pianoforte probabilmente dal padre. Di questo doppio studio apprendiamo notizia da un articolo del quotidiano „Bozner Zeitung“ sul concerto degli allievi del 20 giugno 1872, nel corso del quale Ludwig Thuille, che aveva undici anni aveva suonato consecutivamente violino e pianoforte. Ed è ai due strumenti che aveva imparato a conoscere da piccolo che dedicò la sua prima composizione, la Sonata per pianoforte e violino op. 1.
Ludwig era ancora un ragazzo quando, morti entrambi i genitori e grazie al sostegno di uno zio, entrò nel coro della celebre abbazia di Kremsmünster, una cittadina a sud di Linz, tra Salisburgo e Vienna. Li si trovava il monastero benedettino fondato nel 777 dove i monaci avevano dato vita ad una cittadella della fede, delle arti e delle scienze. Qui avevano studiato l’amico e copista di Mozart Sußmeyer e anni dopo lo scrittore Adalbert Stifter. Chissà se anche Ludwig Thuille, come Stifter, avrà ricordato negli anni il paesaggio trasparente e le albe azzurre che avevano fatto da sfondo ai giorni dei suoi studi umanistici e musicali all’abbazia. Forse non ebbe il tempo di farlo, morirà troppo giovane per vivere gli anni dei ricordi.
A sostenerlo economicamente nei successivi anni di studio, intervenne una benestante signora, Pauline Nagiller, vedova di Matthäus Nagiller, un violinista celebre e amico della famiglia Thuille ai tempi di Bolzano. Grazie al sostegno della signora Pauline, Ludwig si traferì a Innsbruch e poi a Monaco, dove entrerà nel Regio Conservatorio della città per studiare pianoforte, organo e composizione laureandosi nel 1882 con il massimo dei voti in quasi tutte le materie. Furono quelli gli anni in cui Thuille rinsaldò il suo rapporto con Strauss, di cui era amico – grazie a Pauline Nagiller – già dai tempi di Innsbruch. I due ragazzi uno di 13 l’altro di 16 anni (Strauss era il più giovane dei due) avevano trovato un’intesa immediata. A Monaco Thuille divenne un ospite fisso a casa Strauss, dove ogni giorno si faceva musica. Il padre di Strauss, Franz Strauss, non solo era il primo corno dell’Orchestra di Corte, ma era una autentica celebrità, tenuto in grande considerazione da direttori e compositori. Possiamo dunque immaginare facilmente quali e quanti fossero i musicisti che frequentavano la casa. Con Thuille Strauss condivideva innanzitutto il fatto di essere stato anche lui un talento precoce. C’erano pochi anni di differenza tra i due ragazzi, ma bastavano a far sì che Ludwig Thuille esercitasse una forte influenza sul più giovane Richard, il quale lo ricambio sempre con una sincera ammirazione.
Fu Strauss a tenere a battesimo la Sinfonia in fa maggiore dell’amico, dirigendola nel 1886 a Meiningen, dove era diventato direttore dell’orchestra cittadina. In quegli anni la carriera di Strauss e anche quella di Thuille erano fortemente influenzate dalla poetica dei Nuovi Tedeschi, i musicisti che nella Germania del tempo si opponevano alla visione conservativa della musica in quel momento identificata (erroneamente potremmo dire oggi) nell’opera di Brahms. Alexander Ritter, compositore e violinista, coetaneo di Brahms, ma tenace ammiratore di Wagner, cercò di convertire Strauss e Thuille alla religione wagneriana. La musica assoluta era il mondo di Beethoven che in Brahms aveva trovato il suo compimento, ora Liszt e Wagner avevano aperto nuovi orizzonti. Liszt con la musica a programma e il poema sinfonico, Wagner con l’uso estenuato della dissonanza e la melodia infinita. Invero i due ragazzi non erano ancora – in quel periodo – così distanti da Brahms. Infatti fu proprio a casa di Strauss a Meiningen che Thuille incontrò Brahms, il quale l’anno prima, il 1885, aveva presentato al pubblico la sua Quarta sinfonia. Sappiamo che il giorno dell’incontro Thuille aveva con sé la partitura della sua Sinfonia in fa maggiore, ma non sappiamo se poi la mostrò a Brahms, né tantomeno sappiamo se Brahms ne diede un giudizio e quale. Ad un primo sguardo potrebbe addirittura sembrare che la Sinfonia si apra con un omaggio a Brahms, perché Thuille inserisce prima dell’Allegro del primo tempo un Adagio esattamente come aveva fatto Brahms nella sua prima sinfonia, ma il clima è del tutto differente. Ritroviamo invece quella che abbiamo definito fin dall’inizio la caratteristica migliore di Thuille, l’inclinazione alla leggerezza. Infatti è lo stesso Strauss a confermargli il bel successo che la sua sinfonia aveva riscosso presso il pubblico di Meiningen. Con la sincerità di un amico gli parla anche del primo movimento dicendogli che forse era un po’ lungo per l’ascoltatore inesperto, ma sicuramente gli altri movimenti avevano conquistato tutti. Il Minuetto, in particolare, insieme al Largo maestoso, fu assai apprezzato e spesso venne eseguito indipendentemente dalla Sinfonia, come pezzo da concerto. Il Trio di questo Minuetto poi ci porta esattamente nel clima più congeniale a Thuille, la leggerezza colta di un compositore non artificioso, con una visione personale del mondo romantico di Mendelssohn e Schumann, che a dire il vero è ormai distante nel tempo. Ma per lui forse ancora non così tanto…
Nella musica di Thuille riaffiora tutta la tradizione tedesca che faceva parte della vasta cultura dell’autore. E proprio grazie alle sue tante competenze che Thuille entrò ben presto a far parte della vita musicale di Monaco, prima come istitutore privato nella casa del barone Theodor von Dreyfus, poi come docente all’Accademia di Musica, Akademie der Tonkunst dove nel tempo divenne un celebre maestro di teoria e composizione con allievi che iniziarono ad arrivare da lui da ogni parte della Germania e poi da tutto il mondo. E’ stato definito un conservatore, ciò che è vero è che si tenne discosto dalle scelte estetiche dei suoi famosi contemporanei. I suoi più intimi amici erano Richard Strauss e Max Schillings. Avevano personalità differenti. La musica di Thuille non aveva il fascino infinito di quella di Strauss, né il pathos delle composizioni di Schillings, però possedeva una grazia spensierata e un calore comunicativo che traspirano ad ogni pagina. Thuille agli inizi del novecento ebbe un considerevole successo anche come compositore di opere. Soprattutto di un’opera dal titolo Lobetanz che dopo la prima rappresentazione a Karlsruhe il 6 febbraio 1898 venne rappresentata a Monaco e poi a Berlino con la direzione di Strauss. Il librettista dell’opera era Jiulius Bierbaum, un personaggio senza dubbio singolare. Giurista un po’ eccentrico, intellettuale bohémien, all’occasione poeta, fondatore di giornali e riviste che sparivano poco dopo, costantemente senza denaro, e naturalmente scrittore di romanzi, racconti e drammi. Il libretto racconta la storia di una principessa triste la quale non trova chi la liberi dalla malinconia, finché non giunge al castello Lobetanz, violinista e menestrello. Una trama esile per una musica che al contrario si rivelò brillante. Fu un grande successo e circolò a lungo anche dopo la morte dell’autore. Nel 1911, venne presentata a New York al Metropolitan e a Filadelfia.
Dell’opera non esiste alcuna incisione, quello che rimane è l’Ouverture della prima opera di Thuille, Theuerdank, vicenda cavalleresca, ambientata nel tardo quattrocento, su libretto di quell’Alexander Ritter, wagneriano, di cui si è parlato. Fu l’autore stesso in questo caso a salvarne solo l’Ouverture, che poi è entrata nel repertorio come Ouverture Romantica.
Anche per Thuille, come per il prediletto Schumann, gli anni del fidanzamento e i primi del matrimonio furono anni felici anche sotto il profilo creativo. In quel periodo Thuille si dedicò soprattutto al genere a lui più congeniale, la musica da camera. Sappiamo che era un eccellente camerista, e a Monaco era molto richiesto nei concerti di musica di insieme. La musica da camera rimase sempre la sua grande passione. Negli anni dal 1885 al 1887 lavorò alla composizione sua ancora oggi più celebre, il Sestetto per pianoforte e fiati op.6, che non a caso venne dedicato alla moglie, Emma Dietl. Il pezzo, presentato al Festival di Wiesbaden nel 1889, ebbe subito un grande successo. Si tratta di una pagina felicissima, equilibrata e piena di entusiasmo, che ci viene incontro con lo stile di un Brahms che non ha dimenticato la lezione di Schumann. Nonostante tutto questo però è la composizione che meglio ci fa capire il mondo interiore di Thuille. La ricerca del colore del suono appare già da subito con il mormorio del pianoforte che apre lo sguardo ad una scena larga e trasparente, un paesaggio profondo in cui entrerà ben presto il corno e poi gli altri strumenti in un dialogo strumentale pieno di inventiva. Sembra uno scenario di montagna, forse di quelle montagne del Tirolo che Thuille aveva nelle sue origini.
Grande successo avrà anche un’altra composizione cameristica, il Quintetto per pianoforte e archi op. 20, composto sulla fine del secolo, tra il 1898 e il 1901. Nel 1903 l’amicizia tra Strauss e Thuille ebbe un lungo momento di rottura causata da una critica severa pubblicata da Bierbaum, il librettista di Thuille, su un quotidiano. Strauss ritenne che la critica fosse stata ispirata da Thuille e ruppe i rapporti con lui per quasi tre anni. La riappacificazione avvenne grazie ad una lettera di Thuille all’amico, nel 1906, ma i due non ebbero più occasione di incontrarsi perché Thuille morirà a Monaco per un attacco di cuore quando non aveva neppure quarantaseianni, nel febbraio del 1907. Dunque si era rotto per sempre quel sodalizio iniziato quando i due erano ancora ragazzi, quando Strauss scriveva all’amico lettere piene di ammirazione, chiamandolo il più caro, il migliore, il più gentile e magnifico degli amici, e Thuille lo ricambiava di identico affetto. Strauss che pure rimproverava l’amico per essere troppo schumanniano, ma poi chiedeva a lui di aiutarlo – si racconta – a risolvere problemi di contrappunto per la sua Sinfonia Domestica. Un’amicizia testimoniata da molti intensi momenti, dalla dedica di Strauss a Thuille del Don Juan e da parte di Thuille dalla versione del poema sinfonico per pianoforte a quattro mani. Un volume di lettere di oltre duecento pagine testimonia il loro lungo sodalizio. Gli ultimi anni di vita di Thuille sono segnati dal suo grande successo come docente di composizione. In un libro che si intitola “Una ragazza americana a Monaco” è descritta una visita a Thuille da parte di una ragazza, Mabel Daniels, arrivata a Monaco nel 1902. La ragazza ci conduce a casa di Thuille e mentre è in anticamera ad aspettare ci confessa di essere venuta a Monaco principalmente per studiare con il maestro. Thuille parlava poco l’inglese e la ragazza non conosceva che poche parole di tedesco, ma Thuille accettò di farle lezione. Si sarebbero intesi con un po’ di francese – disse – e eventualmente in latino. Così Miss Daniels entrò a far parte del gruppo di compositori, la Giovane Scuola di Monaco, che si riunivano attorno a Thuille: ne facevano parte tra gli altri Ernst Bloch e Walter Braunfels, ed era conosciuto come Le Thuilleries. Nello stesso anno Thuille scriveva la Sonata per pianoforte e violoncello op. 22, la sua ultima opera pubblicata. Una pagina molto felice in cui ritroviamo ancora una volta la disponibilità al canto che Thuille aveva sempre seguito. Quella sua inclinazione così personale è di certo ciò che meglio definisce la sua personalità, plasmata dalle sue origini, un connubio appagato tra melanconia tedesca e spensieratezza latina.